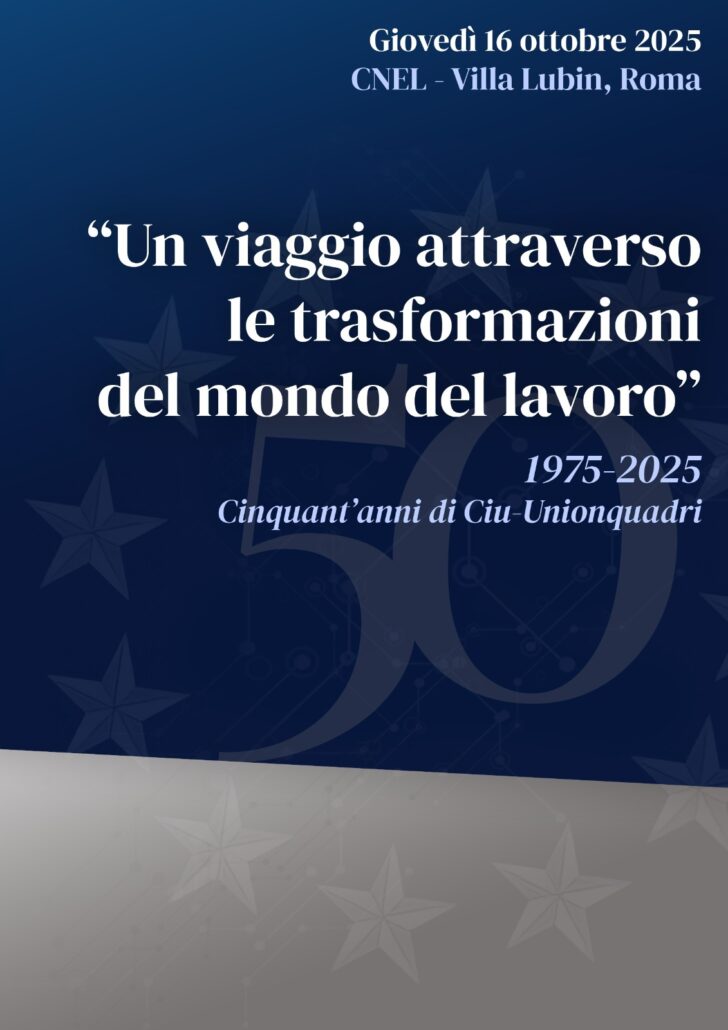Gabriella Ancora, Presidente Nazionale CIU Unionquadri
Andrea Musti, Senior Associate presso Studio Ichino Brugnatelli e Associati, CNEL Componente Consulta lavoro autonomo e Professioni.
Il breve excursus su detta fondamentale categoria di lavoratori subordinati, vuole riassumere alcune delle criticità evidenziate dalla giurisprudenza dalla entrata in vigore della nota legge istitutiva della categoria in esame.
La Legge del 13 maggio 1985 n. 190 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la categoria dei “quadri intermedi”, colmando il vuoto normativo tra la figura del dirigente e quella dell’impiegato. L’articolo 2 della legge definisce il quadro come il prestatore di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, “svolga funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa”. La stessa norma demanda alla contrattazione collettiva il compito di stabilire i requisiti specifici di appartenenza a tale categoria.
Nonostante l’intento chiarificatore del Legislatore, la definizione volutamente generica ha dato origine a un cospicuo contenzioso, portando la giurisprudenza a delineare con maggiore precisione i contorni e le problematiche applicative di questa figura professionale. Di seguito si analizzano le principali questioni giurisprudenziali emerse.
- Applicazione della Legge in assenza di disciplina collettiva
In ordine temporale, una delle prime e più significative questioni affrontate nel tempo dalla giurisprudenza riguarda l’ipotesi in cui la contrattazione collettiva non abbia provveduto, come richiesto dall’art. 3 della legge, a definire i requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri.
La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che la legge n. 190/1985 è “immediatamente precettiva” (cfr. Cass. Civ., Sez. L, N. 1094 del 16-01-2023 e Cass. Civ., Sez. L, N. 680 del 12-01-2023).
Ciò significa che il diritto del lavoratore al riconoscimento della qualifica di quadro è configurabile anche in assenza di una specifica previsione da parte del contratto collettivo di settore. In tale scenario, i requisiti per l’inquadramento devono essere desunti direttamente dalle indicazioni fornite dalla legge stessa.
La giurisprudenza ha chiarito inoltre che, in questi casi, il Giudice deve basare la sua valutazione sull’unico requisito richiesto ex lege: lo svolgimento continuativo di funzioni di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi aziendali. È stato altresì precisato che i giudici di merito non possono aggiungere requisiti ulteriori e non previsti dalla norma, come quelli tipici della figura dirigenziale (ad esempio, la gestione diretta dei rapporti con i terzi o la capacità di impegnare direttamente l’azienda), che la legge sui quadri non richiede.
Sul punto richiamo Cass. Sez. Lav. n. 21652 del 9/10/2006 e Cass. Sez. Lav. n. 2246 del 27/02/1995 per le quali: “… il diritto al riconoscimento della qualifica di “quadro”, istituita dalla legge 13 maggio 1985 n. 190, è configurabile anche se, entro l’anno dall’entrata in vigore della legge, la contrattazione non abbia provveduto, a norma degli artt. 2 e 3, a stabilire i requisiti di appartenenza alla categoria, che, in tal caso, vanno desunti dalle specifiche indicazioni poste dalla legge, considerando che la categoria dei quadri non appartiene alla categoria dei dirigenti e che ai quadri, salvo diversa disposizione, si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati (art.2, commi 1 e 3 legge n.190 del 1985).”
2. I requisiti sostanziali e l’onere della prova
Il nucleo del contenzioso in materia di quadri riguarda l’accertamento in concreto dello svolgimento delle mansioni superiori. L’onere della prova grava sul lavoratore, che deve dimostrare non solo di aver svolto determinate mansioni, ma che queste possiedano le caratteristiche qualitative richieste dalla legge e dalla contrattazione collettiva
La giurisprudenza ha individuato alcuni elementi caratterizzanti la figura del quadro:
Rilevanza delle Funzioni: le mansioni devono essere di “rilevante importanza” per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Non si tratta di compiti meramente esecutivi, ma di attività che incidono significativamente sulla vita dell’impresa.
Autonomia e Discrezionalità: il quadro gode di un’autonomia decisionale e di un’iniziativa che lo distinguono dall’impiegato con funzioni direttive. Tale autonomia, tuttavia, non raggiunge l’ampiezza di quella del dirigente, poiché il quadro opera nell’ambito di direttive generali impartite dalla dirigenza, contribuendo alla loro attuazione piuttosto che alla loro definizione strategica (cfr. Tribunale Ordinario Tivoli, sez. Lav., sentenza n. 733/2017).
Funzione di Raccordo: un elemento qualificante, evidenziato dalla giurisprudenza più recente, è il ruolo di “cerniera” o “raccordo” tra la dirigenza e il personale operativo. La Corte di Cassazione ha specificato che questa funzione di collegamento è un criterio presupposto dalla stessa legge, che la contrattazione collettiva deve rispettare (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav. N. 20288 del 14-07-2023).
Infatti, la legge 13 maggio 1985 n. 190, che ha introdotto la nuova categoria dei “quadri” nella classificazione dei prestatori di lavoro di cui all’art. 2095 cod. civ., “…fornisce dei criteri direttivi, concependo la nuova categoria quale intermedia tra quella dei dirigenti e quella degli impiegati …”. E’, pertanto, la stessa legge a richiedere che la figura del Quadro sia di collegamento tra i dirigenti ed il restante personale e ciò rappresenta un criterio presupposto della contrattazione collettiva (cfr. citata Cass. 20288/2023).
Il giudice di merito è chiamato a compiere una valutazione complessa, comparando le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore con le declaratorie del CCNL applicabile e con la definizione legale: non è sufficiente che le mansioni rientrino in un profilo professionale descritto dal CCNL se mancano i requisiti generali della declaratoria di livello, come l’autonomia, la responsabilità e, appunto, la funzione di raccordo (cfr. Tribunale Di Catania, Sentenza n.1878 del 30 Aprile 2025).
3. Diritto all’Indennità di Funzione
Molti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro prevedono, per i lavoratori inquadrati come quadri, la corresponsione di una specifica “indennità di funzione” (cfr. CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi 19/12/2017; Rinnovo del CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli scaduto il 31/12/2009; nonché Tribunale Di Benevento, Sentenza n.649 del 30 Maggio 2025, etc).
Una problematica giurisprudenziale è sorta riguardo alla spettanza di tale indennità in caso di riconoscimento giudiziale della qualifica, specialmente quando il CCNL subordina l’erogazione a un formale atto di “individuazione” o “riconoscimento” da parte del datore di lavoro.
La giurisprudenza più recente ha superato tale ostacolo formale, affermando un principio di effettività: al riguardo infatti in questa sede è utile ricordare l’importanza della recente sentenza dellaCorte di Cassazione (Sez. Lav. N. 24830 del 16-09-2024) la quale ha stabilito che l’accertamento giudiziale dello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di quadro è di per sé sufficiente a far sorgere il diritto non solo all’inquadramento, ma anche alla relativa indennità di funzione.
Secondo la Corte, dunque, ritenere necessaria una formale nomina datoriale anche a fronte di un accertamento giudiziale creerebbe una “ingiustificata differenziazione” e penalizzerebbe il lavoratore che ha dovuto agire in giudizio per vedere riconosciuti i propri diritti. Pertanto, il riconoscimento giudiziale della qualifica ha efficacia piena e comporta l’attribuzione di tutti gli elementi, anche economici, che ne conseguono, come l’indennità di funzione.
4. La prescrizione dei diritti
Un’altra area di frequente dibattito riguarda la prescrizione dei diritti derivanti dallo svolgimento di mansioni da quadro. La giurisprudenza distingue nettamente tra:
- Diritto alla qualifica: Soggetto alla prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.).
- Diritto alle differenze retributive: Soggetto alla prescrizione breve quinquennale (art. 2948 c.c.).
L’errore che spesso viene commesso, e che la Cassazione ha più volte censurato, è quello di applicare preliminarmente la prescrizione quinquennale ai crediti retributivi e, solo successivamente, verificare se nel periodo non prescritto il lavoratore abbia svolto mansioni superiori.
L’approccio corretto, indicato dalla Suprema Corte, è inverso:
- Prima accertare il fatto genetico del diritto: Il giudice deve verificare se e quando il lavoratore ha iniziato a svolgere mansioni da quadro, sulla base della normativa vigente in quel momento (cfr., citate, Cass. Civ., Sez. L, N. 1094 del 16-01-2023 e Cass. Civ., Sez. L, N. 680 del 12-01-2023)
- Poi verificare l’eventuale estinzione per prescrizione: Solo una volta stabilito che il diritto alla qualifica e i conseguenti diritti patrimoniali sono sorti, si può valutare se siano stati estinti per il decorso del tempo.
Non è invece giuridicamente corretto considerare dapprima la prescrizione (“..tanto più dei crediti, che è ancorata al decorso di termine più breve rispetto alla prescrizione della qualifica ..”) e poi verificare se, nel tempo non coperto da prescrizione, siano state svolte mansioni diverse da quelle originarie e se quelle siano superiori in relazione al quadro normativo vigente al momento di maturazione della prescrizione: la legge infatti prevede la nascita di diritti derivanti dallo svolgimento delle mansioni superiori e, per converso, la loro estinzione; è “..dunque corretto verificare dapprima se un diritto sia sorto, per poi vedere se sia sopravvissuto o meno alle cause legali di estinzione” (cfr. sentenze Cassazione da ultimo citate).
In conclusione
L’introduzione della categoria dei quadri con la Legge n. 190/1985 ha rappresentato un’importante evoluzione del diritto del lavoro. Tuttavia, la sua applicazione pratica è stata costellata di incertezze, risolte in gran parte dall’intervento chiarificatore della giurisprudenza. Le Corti hanno consolidato principi fondamentali quali l’immediata precettività della legge, la centralità del ruolo di raccordo del quadro, il diritto automatico all’indennità di funzione a seguito del riconoscimento giudiziale e la corretta metodologia per l’applicazione della prescrizione, garantendo così una tutela più efficace e sostanziale per questa fondamentale figura professionale.